
Un tesoro che torna. Oltre 80 opere, tra cui il Baccanale degli Andrii di Tiziano (uno dei capolavori del Camerino delle pitture di Alfonso d’Este che grazie ad un prestito eccezionale concesso dal Museo del Prado è tornato in Italia dopo quasi 500 anni dalla sua creazione) e diversi capolavori del nostro Rinascimento, sono riunite a Palazzo dei Diamanti per dare vita ad un appuntamento irripetibile che rievoca il fantastico mondo cavalleresco di “Orlando e dei paladini” in occasione del cinquantenario dalla sua pubblicazione, proprio a Ferrara.
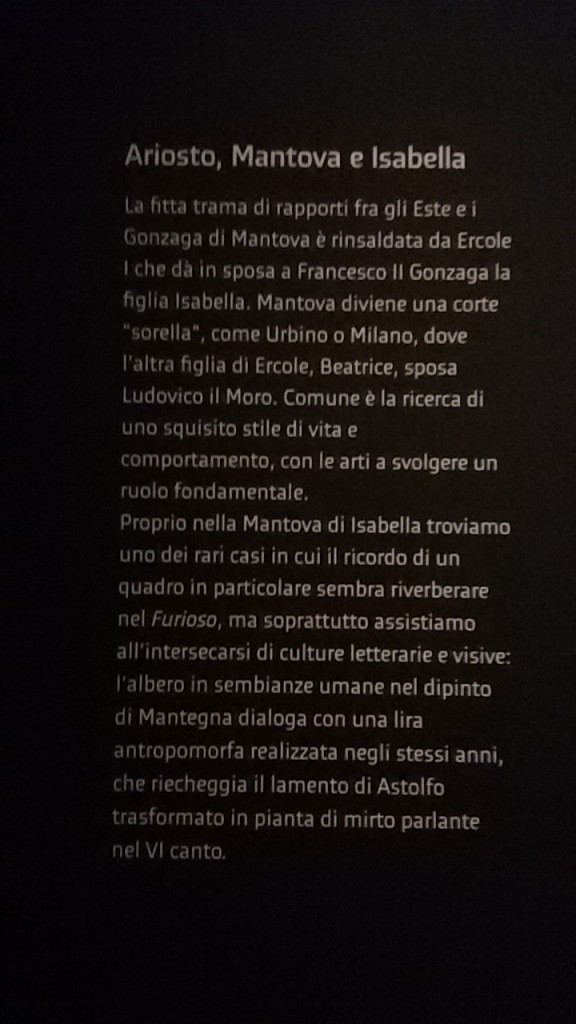

Una mostra che fa dialogare dipinti, sculture, arazzi, libri, manoscritti miniati, strumenti musicali, armi e oggetti preziosi per restituire l’universo di immagini che popolavano la mente di Ariosto mentre componeva il Furioso.
Quali libri e quali opere d’arte furono le muse del suo immaginario?

Tutto ciò è svelato nell’itinerario della mostra, ordinato in sezioni tematiche che alternano le fonti dell’immaginario al contesto in cui è nato il poema: dall’universo delle battaglie all’evocazione di un’elegante vita di corte, dalla fascinazione per i viaggi alle immagini di condottieri reali e leggendari. La corte è di per sé un luogo teatrale, vive di una continua rappresentazione di se stessa, attraverso le proprie immagini di vita, dall’arte alla caccia con il falcone fino al gioco (degli scacchi, delle sorti, o dei tarocchi), gli abitanti della corte ritrovavano nel romanzo cavalleresco il modello di uno stile di vita moralmente elevato, basato sull’eleganza dei costumi e sulla raffinatezza degli svaghi.
Il centro “de La città” di Ludovico Ariosto era l’atmosfera cortigiana, carica di stimoli, specie sotto l’egida di Ercole I e Alfonso I d’Este, di cui il poeta scrisse a lungo. I suoi componimenti teatrali e i canti del poema animavano sia i banchetti in Castello sia le rappresentazioni nell’odierna Piazza Municipale.

Anonimo Portoghese, Charta del navicare per le isole novamente trovate in la parte de l’India (detta del Cantino), 1501-02 Manoscritto a inchiostro e tempera su pergamena in sei pezzi giuntati, mm 1050 x 2200 Modena, Biblioteca Estense Universitaria. Su concessione del MiBACT
Il tempo di Ariosto fu segnato sia dalle grandi scoperte geografiche, (quelle di Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci, così come dalle relazioni dei viaggi in terre sconosciute e “meravigliose”. Ariosto visse questa esperienza attraverso le pagine dei libri e le carte di navigazione, come quella detta del Cantino, capolavoro della cartografia rinascimentale tra le prime a registrare le scoperte del nuovo mondo e la via marittima recentemente aperta da Vasco da Gama) che dalla nascita dei dipinti che artisti come Dosso o Tiziano dipingono per il Ducato ed assiste alla rivoluzione linguistica della pittura, vedendo di persona le opere di Michelangelo e Raffaello che lo stesso Alfonso I d’Este, signore di Ferrara, brama di possedere.
 Cosa vedeva dunque il poeta, chiudendo gli occhi, quando si accingeva a raccontare una battaglia, un duello di cavalieri o il compimento di un prodigioso incantesimo?
Cosa vedeva dunque il poeta, chiudendo gli occhi, quando si accingeva a raccontare una battaglia, un duello di cavalieri o il compimento di un prodigioso incantesimo?
Le gesta dei paladini di Carlo Magno, rappresentati da due simboli: il labirinto in cui i protagonisti delle “audaci imprese” si smarriscono e il bivio, la scelta tra il bene e il male, che si pone continuamente innanzi ai cavalieri. Il primo è raffigurato sulla giubba di un misterioso ed elegante cortigiano ritratto da Bartolomeo Veneto, il secondo appare sulla specchiera istoriata con l’emblema di Alfonso I d’Este, squisito esemplare dell’arte dell’intaglio ligneo del primo Cinquecento.
 E poi un mondo di maghi, d’incantesimi, di fate. Le avventure sono ambientate in un passato leggendario e avvolte in un’atmosfera favolistica. Cuore pulsante del percorso, la prima edizione dell’Orlando furioso è il perno di una sala che approfondisce i due poli su cui ruota l’intera vicenda – il desiderio e la follia – permettendo così al visitatore di “immergersi” nel senso più autentico della storia. Si parla di sentimenti e passioni dell’uomo moderno, indagati dall’autore con sguardo lucido e disincantato. L’Orlando furioso è, in tutti i sensi, un poema sul desiderio. Ciascun personaggio è infatti instancabilmente all’inseguimento dell’oggetto dei propri sogni, di qualcosa che non riesce a possedere, sia esso un’arma, un cavallo, una persona. Due soli pezzi sono chiamati a illustrare tale concetto: un elmo antico simboleggia le mitiche armi di Ettore conquistate e perdute dai protagonisti del poema. Di fronte ad esso, una Venere di Botticelli, immagine esemplificativa di una bellezza femminile, ideale e astratta. Opera che per antonomasia rappresenta la grazia femminile alla fine del Quattrocento, la Venere botticelliana, la fulgida dea, vestita solo di un sottilissimo velo che lascia intravedere le grazie del corpo, nel nudo splendore della sua bellezza: «Con bionda chioma lunga et annodata: / Oro non è, che più risplenda e lustri» (VII, 11, v. 3-4).
E poi un mondo di maghi, d’incantesimi, di fate. Le avventure sono ambientate in un passato leggendario e avvolte in un’atmosfera favolistica. Cuore pulsante del percorso, la prima edizione dell’Orlando furioso è il perno di una sala che approfondisce i due poli su cui ruota l’intera vicenda – il desiderio e la follia – permettendo così al visitatore di “immergersi” nel senso più autentico della storia. Si parla di sentimenti e passioni dell’uomo moderno, indagati dall’autore con sguardo lucido e disincantato. L’Orlando furioso è, in tutti i sensi, un poema sul desiderio. Ciascun personaggio è infatti instancabilmente all’inseguimento dell’oggetto dei propri sogni, di qualcosa che non riesce a possedere, sia esso un’arma, un cavallo, una persona. Due soli pezzi sono chiamati a illustrare tale concetto: un elmo antico simboleggia le mitiche armi di Ettore conquistate e perdute dai protagonisti del poema. Di fronte ad esso, una Venere di Botticelli, immagine esemplificativa di una bellezza femminile, ideale e astratta. Opera che per antonomasia rappresenta la grazia femminile alla fine del Quattrocento, la Venere botticelliana, la fulgida dea, vestita solo di un sottilissimo velo che lascia intravedere le grazie del corpo, nel nudo splendore della sua bellezza: «Con bionda chioma lunga et annodata: / Oro non è, che più risplenda e lustri» (VII, 11, v. 3-4).
 Il desiderio inappagato per Angelica è la causa dell’impazzimento di Orlando, del suo allontanamento dalla sfera della razionalità. La follia del paladino, come le insensatezze degli altri personaggi costituiscono l’esempio per riflettere sulle passioni e i sentimenti che possono annullare, in ciascun individuo, la percezione dei propri limiti. Questo tema permette dunque di immergere l’Orlando furioso nella cultura europea del primo quarto del Cinquecento: la concezione della follia che si afferma nel poema ariostesco, che affonda le sue radici nella classicità ed è condizione comune a tutto il genere umano. Al folle mondo degli uomini Ariosto oppone la luna, astro identico alla terra tranne che per il fatto che la pazzia vi è assente. È lassù che Astolfo, accompagnato da san Giovanni (Cosmè Tura, San Giovanni a Patmos), recupererà il senno perduto da Orlando. Ariosto la descrive lucida e riflettente come una sfera di acciaio politissima; una visione affine a quella di Leonardo da Vinci che la paragona alle «palle dorate poste nella sommità degli alti edifizi», come il Globo dell’obelisco vaticano esposto nella mostra, al tempo di Ariosto, era visibile a Roma in San Pietro.
Il desiderio inappagato per Angelica è la causa dell’impazzimento di Orlando, del suo allontanamento dalla sfera della razionalità. La follia del paladino, come le insensatezze degli altri personaggi costituiscono l’esempio per riflettere sulle passioni e i sentimenti che possono annullare, in ciascun individuo, la percezione dei propri limiti. Questo tema permette dunque di immergere l’Orlando furioso nella cultura europea del primo quarto del Cinquecento: la concezione della follia che si afferma nel poema ariostesco, che affonda le sue radici nella classicità ed è condizione comune a tutto il genere umano. Al folle mondo degli uomini Ariosto oppone la luna, astro identico alla terra tranne che per il fatto che la pazzia vi è assente. È lassù che Astolfo, accompagnato da san Giovanni (Cosmè Tura, San Giovanni a Patmos), recupererà il senno perduto da Orlando. Ariosto la descrive lucida e riflettente come una sfera di acciaio politissima; una visione affine a quella di Leonardo da Vinci che la paragona alle «palle dorate poste nella sommità degli alti edifizi», come il Globo dell’obelisco vaticano esposto nella mostra, al tempo di Ariosto, era visibile a Roma in San Pietro.
Così il poema di Ludovico Ariosto, Composto di 40 canti, un capolavoro “italiano”, simbolo della letteratura del primo Rinascimento, che ambiva a cantare «le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese» aveva un solo ed unico denominatore comune: la bellezza per tutto ciò che è arte. Se ne accorse Cervantes che omaggiò la grandezza del poema ariostesco nel Don Chisciotte, libro che congeda il visitatore al termine di questo viaggio.
Visitare la mostra oggi è stato come tornare indietro nel tempo. A scuola, ultimo anno delle superiori con il Prof. Vittorio Sgarbi alla sua prima supplenza di italiano e storia. Lo studio di queste materie, ovviamente, ma a quel tempo del tutto nuovo originale, passava attraverso l’arte.
Info e prenotazioni: www.palazzodiamanti.it tel.0532 244949 diamanti@comune.fe.it
Tag:arte, Ferrara, mostra

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It












